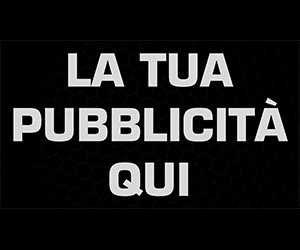Paola Del Negro (© C.A. Dallagiacoma)
TRIESTE – Fra un anno e mezzo scadrà il suo secondo mandato da direttrice generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste.
«Un punto di riferimento scientifico a livello nazionale e internazionale», ama ripetere Paola Del Negro, laureata in Scienze Biologiche e membro del Collegio di Dottorato in Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Trieste.
Paola Del Negro, cosa significa dirigere l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale?
«Io sono una ricercatrice. Mi sono occupata di ricerca fino al 2012 quando sono diventata direttrice della Sezione di Oceanografia. Sono passata dalla “ricerca sul campo”, dalle campagne oceanografiche e dallo scrivere pubblicazioni alla gestione di questo mondo, ma rimanendo comunque confinata all’interno dell’area di mia competenza: il mare».
Un passaggio traumatico?
«Nel 2018, per una serie di occasioni fortuite (si era dimesso il direttore generale di OGS e non si riusciva a organizzare un bando per reclutare una persona esterna) hanno assegnato a me la direzione generale dell’Istituto. Ho dovuto abbandonare la mia linea di comfort che era quella del mare per occuparmi di tutte le anime che caratterizzano questa realtà. Che sono diverse».
Mare e non solo…
«Oltre alla grande competenza sull’oceanografia, noi siamo anche un Istituto di Geofisica sperimentale e applicata. Studiamo la terra. Mi sono così calata in questa realtà competente con una grande storia e una grande tradizione all’interno di OGS. Proprio nell’ambito di questo studio della terra OGS ospita il Centro di Ricerche Sismologiche, con sede a Udine. Una realtà di cui io – friulana che ha vissuto sulla propria pelle il periodo del terremoto e post terremoto – ho sempre apprezzato tantissimo il valore».
La sua direzione finora è stata florida di soddisfazioni.
«È stata una scoperta anche di competenze, storie e progetti che prima solo mi sfioravano. Grande arricchimento personale, ma anche grandi pensieri: quando lo avevo preso in mano, in OGS c’erano meno di 200 persone, ora invece siamo più di 400. Una grande evoluzione, non certo per merito mio. L’arrivo dei fondi PNRR post COVID ha consentito di ampliare e potenziare le nostre attività: abbiamo anche acquistato la nave per ricerca “Laura Bassi”, unica rompighiaccio battente bandiera italiana. Riguardando questo periodo di direzione generale posso affermare di avere imparato tante cose, molte a mio danno, ma con un arricchimento umano e professionale. OGS è un ente complesso che racchiude competenze molto diverse in una realtà molto coesa, rappresentando un punto di grande forza».

Gli altri punti di forza?
«Abbiamo una capacità di presentazione di progetti e di loro approvazione più alta della media nazionale. Ma possediamo anche forti relazioni con le imprese e abbiamo una grande capacità di gestione di infrastrutture strategiche. Oltre alla nave, gestiamo per conto dell’Italia tre infrastrutture europee: ARGO, il più grande sistema mondiale di osservazione in situ degli oceani, di cui OGS ne è responsabile per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero; ECCSEL, infrastruttura europea dedicata allo stoccaggio sottoterra dell’anidride carbonica; PRACE, infrastruttura europea per il supercalcolo, con focus sulle applicazioni modellistiche per le Scienze della Terra. Senza scordare le reti osservative, di cui quella sismologica è la più importante che monitora tutta l’Italia nordorientale».
Quali invece i punti che a suo avviso andrebbero migliorati?
«La logistica. Siamo cresciuti tanto: sia la sede di Trieste che quella di Udine necessitano di ampliamenti, per non influenzare negativamente il benessere delle persone che lavorano. Un altro limite sono i vincoli legati al fatto di essere un ente pubblico, con poca possibilità di incentivare i nostri ricercatori premiandone economicamente il merito. Ricercatori come i nostri che vincono progetti europei, che risultano tra i migliori in Italia, sarebbe opportuno riuscire a gratificarli. Invece battagliamo ancora tra vincoli di reclutamento importanti e stipendi relativamente bassi rispetto al mercato di realtà analoghe alle nostre, con il rischio costante di perdere persone di qualità. Ritengo che migliorare la qualità della vita delle persone che lavorano sia una priorità».
Ribaltiamo la prospettiva: quali sono le caratteristiche indispensabili che deve possedere chi vuole lavorare in OGS?
«Al di là di chi salva vite, noi facciamo il lavoro più bello del mondo. Un lavoro molto utile perché contribuiamo al benessere del pianeta. Un ente, però, non è fatto solo di ricercatori: per garantire la gestione c’è necessità di personale tecnico e amministrativo che, lavorando nel pubblico, ha la garanzia di percepire con regolarità gli stipendi. Chi desidera lavorare per OGS deve avere la voglia di lavorare in gruppo perché ci sono attività che non si possono fare da soli».
Per Paola Del Negro cosa rappresenta la ricerca?
«Sono una persona estremamente curiosa: è la scoperta continua, la voglia di mettersi in gioco attraverso il desiderio di imparare sempre qualcosa. Uno stimolo enorme nella mia vita. Che ora cerco di trasferire anche nelle questioni amministrative, come ad esempio imparare a raggiungere accordi sindacali piuttosto che altri temi».
E invece il mare e l’ecosistema marino?
«Sono parte della mia vita. Nonostante sia carnica di origine, mi è capitato di imbattermi nel mare per puro caso quando ero studentessa, ed è stata una folgorazione. Parlo di mare come se parlassi di me. Lo vedo come il mio mondo. Mi sento perfettamente a mio agio quando mi trovo dentro il mare. Per questo amo il mio lavoro che aiuta le persone a comprendere quanto questo ambiente sia importante».
Oggi il mare cosa ci comunica sullo stato di salute del nostro pianeta?
«Grandi preoccupazioni e grandi criticità. La circolazione oceanica si sta modificando e le acque diventano sempre più acide. C’è una riduzione del ph e una perdita della biodiversità. Se butto un sacco di immondizie in un prato resta lì per tanto tempo davanti ai nostri occhi. Se lo getto in mare sparisce subito in profondità e non dà l’idea del pesante inquinamento. Osservando il mare si ha sempre l’impressione che tutto funzioni bene, ma in realtà non è così. Ogni azione che avviene sulla terra ha delle ripercussioni pesanti su quello che è l’ecosistema più grande del pianeta. Noi siamo abituati a parlare di mari e oceani. In realtà c’è solo un unico grande oceano collegato dai Poli all’Equatore al cui interno ci sono i vari mari costieri, peraltro caratterizzati da grande biodiversità».
Una biodiversità sempre più a rischio.
«Stiamo rovinando l’ecosistema in modo massiccio non solo con la plastica, ma anche con altri inquinanti, con i rumori delle imbarcazioni, con la pesca indiscriminata non per nutrire le persone ma per fare farina di pesce con cui alimentare anche animali d’allevamento. Scelte a mio avviso assurde, compiute ragionando solo all’immediato e non pensando che c’è anche un futuro da preservare. E così ora ci ritroviamo conseguenze che possono diventare catastrofiche. Un mio collega ha scritto un post in occasione della Giornata degli Oceani: “Il mare non ha bisogno di essere celebrato, ha bisogno di un vero cambio di rotta”. Non serve aggiungere altro».
Lei ha partecipato a diverse campagne oceanografiche in Italia e nel mondo, fino in Antartide. Cosa si prova durante queste esperienze sul campo?
«A parte l’ambiente che affascina, la nave è un luogo di lavoro circoscritto. Si lavora tanto e spesso in ambienti molto ristretti. Il noleggio di una nave che ospita 15-20 ricercatori costa decine di migliaia di euro al giorno, per cui bisogna far fruttare il tutto, lavorando h24. Lavoro che richiede una grande squadra, con i singoli componenti che devono adempiere ai propri compiti. Queste campagne oceanografiche, poi, sono molto gratificanti a livello umano: nascono legami che durano nel tempo con ricercatori provenienti da tutte le parti del mondo».

Il suo percorso di formazione è strettamente legato al Friuli Venezia Giulia, con gli studi nelle Università di Trieste e di Udine: come giudica lo stato di salute del mondo della ricerca nella nostra regione?
«Molto bene. Il mio cruccio, tuttavia, è che questa ricerca abbia avuto finora poche ricadute sul contesto locale. Tra università ed enti di ricerca, la nostra regione è una delle più ricche da questo punto di vista. Ma il mondo delle scuole superiori – dagli studenti agli insegnanti – non ci usa. Se dovessi fare una lezione di neuroscienze chiamerei i migliori neuroscienziati, allo stesso modo se dovessi fare una lezione sul mare dovrebbe essere scontato chiamare un esperto di OGS. Ma non è così».
Come mai?
«Credo dipenda molto dai rapporti e dalle persone. Con i rettori delle università di Udine e Trieste si sono creati legami forti tra istituzioni, con la partecipazione condivisa a manifestazioni. Dobbiamo fare un salto di qualità che possa avere una ricaduta fondamentale su tutto il territorio».
Qual è il rapporto di OGS con i diversi portatori di interesse della regione?
«Abbastanza buono, con fatica. Cito spesso l’esempio dei pescatori: vedevano il mondo della ricerca come qualcosa di ostile che voleva mettere dei paletti alle loro attività. C’era diffidenza. Ora invece c’è una collaborazione ottima, che punta a lavorare con un obiettivo comune: salvaguardare il loro lavoro e l’ambiente. Abbiamo instaurato rapporti molto buoni con i Gestori degli impianti di depurazione, mentre con la Regione lavoriamo in stretta collaborazione. Siamo visti come un punto di riferimento e vorrei che con tutti i portatori di interesse si potenziassero queste collaborazioni».
Dal mondo istituzionale alla quotidianità: qual è il suo rapporto con il Friuli Venezia Giulia?
«Ritengo realmente che questo sia un piccolo compendio dell’universo. Oltre che del mare sono innamorata della Carnia: delle sue montagne e dei suoi paesi. Viviamo in un territorio bellissimo, talvolta non compreso fino in fondo dalle persone che lo vivono. Io mi sento fortemente friulana, con i valori di questa terra: senso del dovere e timore di non essere all’altezza. Stati d’animo che rischiano di farci diventare i peggiori nemici di noi stessi».
Quali sono i sogni che Paola Del Negro vorrebbe ancora realizzare?
«Fra un anno e mezzo, alla scadenza del mio secondo mandato, mi piacerebbe lasciare l’OGS meglio di come l’ho trovato, consolidando un’organizzazione che possa facilitare la guida di chi verrà dopo di me. Mi auguro di continuare a fare attività di divulgazione per far comprendere alle persone l’importanza del mare e dell’educazione al rispetto per l’ambiente. Spero che la mia mente continui a essere vivace: vorrei scrivere dei testi per bambini, per spiegare gli animali marini e i rapporti tra loro. Per iniziare un percorso di formazione al mare che attualmente non c’é».