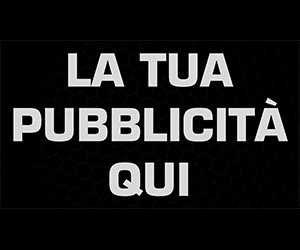INFORMATIVA PRIVACY COOKIES
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul portale imagazine.it è resa all'utente in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
La presente Cookie Policy è relativa al portale imagazine.it .
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata a info@imagazine.it.
Puoi utilizzare la stessa email per esercitare in qualsiasi momento i diritti che il Codice ti attribuisce in qualità di interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.), nonché per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati.
I tuoi dati personali sono trattati in ogni caso secondo le normative in vigore e non sono comunicati né diffusi.
Cosa sono i Cookie?
I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito, ecc.
Quanti tipi di cookie esistono?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).
I cookie possono essere ulteriormente distinti in:
- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
- cookies essenziali sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.
- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione; cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente.
- cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente.
- cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando.
- cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte).
- cookies di condivisone sui Social Network, facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter, solitamente vengono considerati cookie di terze parti.
Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser. Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet.
Per sapere come attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi:
I cookie tecnici e gli analytics sono alcuni dei cookie che usiamo per rendere la tua navigazione piacevole.
La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
Questo sito fa uso di cookie di terze parti per:
Monitorare le visite e ottenere statistiche sull'attività degli utenti nel sito
- Google Analytics per il monitoraggio delle visite e per l'ottenimento di statistiche sull'attività del sito. Maggiori informazioni sono contenute nella privacy policydi Google Analytics.
Condividere sui social network le pagine di questo sito:
Per maggiori informazioni dei singoli servizi scorrere la pagina e vedere le privacy policy rispettive ai singoli servizi
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Commento dei contenuti, Contattare l'Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne, Pubblicità, Remarketing e Behavioral Targeting, Statistica e Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Contattare l'Utente
Modulo di iscrizione
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di iscrizione, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
I nomi inseriti nel modulo di iscrizione sono gli stessi dati che serviranno per firmare gli articoli pubblicati sul blog, pertanto di fatto non sono da considerarsi pubblici. Spetta all’utente la scelta di utilizzare il proprio nome o un alias (quest’ultimo previo richiesta scritta a ilmondocheiosono@beezzup.com) o email appositamente create.
Dati personali raccolti: Cognome e Nome (o alias), Email.
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati personali raccolti: Cognome, Email e Nome.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da queste applicazioni sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Addthis per integrare velocemente le funzioni di share e monitorare le condivisioni.
Maggiori informazioni sono contenute nella privacy policy di AddThis.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante “Linkedin” e widget sociali di Linkedin (Linkedin)
Il pulsante “Linkedin” e widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con la piattaforma Linkedin, forniti da Linkedin Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Embed di Slideshare, per incorporare presentazioni. Maggiori informazioni sono contenute nella privacy policy di SlideShare.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Modifiche a questa policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.